
Povera Irlanda. Aver ottenuto a metà settembre lo sblocco di una tranche da un miliardo di euro del prestito di 85 miliardi concesso dalla Ue non le è bastato a ritrovare il sorriso. Due giorni dopo, i dati sul prodotto interno lordo spiegavano crudelmente che la recessione iniziata nel 2007 non era affatto finita, e che due anni di aiuti saranno sì serviti ad accontentare Berlino – il deficit per rapporto al Pil è passato dal 30 al 9 per cento – ma hanno ucciso la crescita e il lavoro. «Il crollo della domanda interna è davvero spaventoso», dice in un comunicato Paul Sweeney, capo economista dell’Irish congress trade unions. «Quella irlandese è tra le peggiori performance economiche in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale, quasi 70 anni fa». Un calo del 27,5 per cento rispetto al 2008, un quarto in meno, per non parlare delle cifre sull’occupazione, con più di 33mila posti persi negli ultimi mesi. Fortuna che gli irlandesi gli scioperi li fanno poco e nulla, così che la protesta contro i tagli e la disoccupazione resta confinata alle singole fabbriche o ai quartieri dimenticati delle periferie, dove mancano servizi e scuole. In questo modo il premier Enda Kenny non deve far fronte a una popolazione inferocita, ma solo a un sindacato che lo contesta ma non ha gli strumenti per bloccarne le politiche. Però l’Irlanda, a detta di tutti, «soddisfa le condizioni poste dall’Europa». Cioè tirare la cinghia fino allo stremo, così tanto che persino il Fondo monetario internazionale comincia a pensare che forse si è esagerato.
Eppure la Germania, il 25 settembre scorso, ha semi affossato la proposta fatta tre mesi prima da Mario Draghi a nome della Banca centrale europea. Da Helsinki il ministro degli Esteri tedesco Wolfang Schauble, assieme al suo omologo finlandese Jyri Häkämies e all’olandese Jaan Kees de Jager, ha spiegato che il nuovo Fondo salva Stati voluto dalla Bce «potrà intervenire solo in ultima istanza, dopo che lo avranno fatto il capitale pubblico e privato». Una doccia fredda per l’Irlanda, ma anche per Spagna e Italia. Un cazzotto tra i tanti per la Grecia, ormai sfinita come un pugile suonato che aspetta solo il gong finale per abbandonare il ring. “L’estate indiana dell’euro è già finita”, ha titolato l’Economist a fine mese. La stagione intensa ma breve delle speranze – per i mercati, non per la gente – si è dissolta davanti al gelo delle parole di Schauble. Come ha ben sintetizzato l’economista irlandese Karl Whelan sulle colonne dello stesso giornale, i tre Paesi del Nord hanno più o meno rudemente detto a quelli del Sud che possono drop dead, crepare.
Christine Lagarde, invece, non ci sta. La presidente del Fondo monetario non parla moltissimo con la stampa, ma in vista del vertice di Tokyo del prossimo 9 ottobre qualcosa l’ha detta. «Preoccupazione per il debito greco», certo, ma anche per «il rigore di Spagna e Portogallo». Non perché non ce ne sia abbastanza, ma perché ce n’è troppo. «Quando è necessario siamo i primi a sostenerlo, ma quando non ce n’è bisogno può essere controproducente», ha spiegato l’ex ministro delle Finanze francese, cresciuta sotto il magistero di Nicolas Sarkozy e Jacques Chirac. Insomma, nella frenesia di fare i bravi, Mariano Rajoy e Pedro Passos Coelho sono andati oltre il compito assegnato. E più che le manifestazioni di piazza saranno le reprimende delle istituzioni internazionali a far ritornare sui propri passi i due leader iberici.
Lo spagnolo Rajoy è ormai sotto assedio. Lo insultano “indignados” e sindacati, combatte contro le spinte secessioniste ed è così debole da aver costretto il re – scandalosamente – a uscire dal suo riserbo per intervenire nella politica spagnola.
Dal canto suo il portoghese Passos Coelho ha rinunciato all’idea di risparmiare aumentando del 7 per cento i contributi dovuti dai lavoratori, e il 21 settembre ha garantito che troverà «soluzioni alternative». Anche qui c’è voluto l’intervento del presidente della Repubblica Anibal Cavaco Silva per convincerlo a fare un passo indietro. Perché non si può arrivare a essere, come si dice in giro, “più troikista della troika”.
Chissà se il premier portoghese salverà il suo mandato. La sua marcia indietro, per ora, non basta a chi lo contesta – più di un milione il 15 settembre, duecentomila il 29, con il sindacato che promette lo sciopero generale. L’ultima volta che il Portogallo ha incrociato le braccia è stato il 22 marzo scorso, riscuotendo un’adesione pressoché totale. «Facciamo finire il governo di Passos Coelho prima che il governo faccia finire questo Paese», dicono i manifesti lungo le strade di Lisbona. «Attenzione però, tra il Pds di Coelho (centrodestra) e il Ps di José Socrates (centrosinistra) non c’è differenza», avverte Fernando Mendes, graphic designer. Mendes è il fondatore di Cowork, uno spazio di lavoro collettivo nel cuore della capitale, 650mq con vista sul Tejo (Tago), scrivanie da 150 euro al mese o uffici volanti da 10 euro al giorno. La crisi qui non è arrivata solo perché l’hanno schivata inventando un nuovo modello di produzione. Ma altrove non è così. «Ci mancano i soldi – dice Mendes – non la speranza e il coraggio. I portoghesi sono un popolo speciale. Mai contenti, sempre pessimisti, anche quando negli anni Novanta a Lisbona arrivavano tonnellate di euro». C’è sempre un agente esterno a determinare i destini portoghesi: «Con la troika abbiamo un complesso rapporto di inferiorità, spiega Mendes. «Rappresenta i ricchi d’Europa, qualcosa di molto lontano. Li vediamo come avvoltoi, persone senza sentimenti, arrivate solo per farci ancora più poveri. Ma la verità è che fin dagli anni 80, qualunque fosse il governo, abbiamo solo sprecato il nostro denaro». Ora si pagano i conti, ma chi ha mangiato si è già alzato dal tavolo. Davanti al Palácio de São Bento, sede del Parlamento lusitano, un gruppo di artisti ha schierato migliaia di soldatini di plastica. In mezzo, decine di radioline trasmettono sogni raccontati da ragazzini, il futuro che non ci sarà. La voce infantile si alza, si allunga. Ma non supera lo sbarramento delle guardie, quelle in carne e ossa.
E se la crisi la pagassero le tasse dei ricchi? Hollande lo ha annunciato in campagna elettorale, ma ancora non l’ha fatto. Non è l’unica promessa che fatica ad attuare, visto che in 50mila gli hanno contestato, il 30 settembre, il mancato referendum sul fiscal compact. In piazza c’era tutta la sinistra non governativa, mancavano solo i Verdi di Eva Joly che, pur non volendo il trattato, siedono nella coalizione di governo e non possono scendere a marciare sulla Bastiglia. Hollande, preso tra la necessità di accreditarsi nella Ue e quella di non scontentare il suo elettorato, per il momento prende tempo. Mentre a chiedere a gran voce una patrimoniale cominciano i tedeschi, non quelli che sostengono Angela Merkel e la sua politica di rigore, ma l’opposizione di sinistra, dai socialdemocratici alla Linke. Quaranta le città coinvolte nelle proteste, 40mila manifestanti in tutto secondo la polizia, molti di più – ma non hanno fornito cifre – secondo gli organizzatori. Non è il numero che importa, ma la capillarità della proposta. Con una Merkel che deve far fronte ai malumori del suo partito, con il rischio che la Grecia non ottemperi ai suoi impegni (costringendo la Ue a concedere lo stesso gli aiuti, pena l’implosione della zona euro) e con la Spagna che alla fine sarà obbligata a chiedere un programma di protezione, la protesta che si scatena in casa non può far felice la Cancelliera. Non è più il sud che preme ai confini, è un attacco che arriva da più fronti. Anche da est, dove la fida Polonia, sbocco commerciale privilegiato per Berlino, è scesa in piazza contro l’aumento dell’età pensionabile.
La crisi corre, e l’unica cosa che la Bce allo stato attuale può comprare è il tempo, altro che bond. Nessuno ha una soluzione in vendita. Anzi, quasi nessuno. Il 25 settembre, all’Assemblea delle Nazioni unite di New York, il ministro degli Esteri islandese ha catturato l’attenzione di tutti. Rekjavjick alla crisi c’è arrivata per prima, e per prima ne è uscita. «Non vogliamo darvi lezioni, ma l’austerità da sola non funziona», ha dichiarato umilmente Össur Skarpheoinsson. «Abbiamo fatto diversamente e oggi possiamo vantare uno dei tassi di disoccupazione più bassi in Europa e una solida crescita economica. Il modello islandese funziona».
Un modello che non ha tagliato salari, non ha eliminato i soldi per il welfare, non ha strozzato i suoi cittadini. Ma è un modello che ha un difetto imprescindibile: ha lasciato che le banche si arrangiassero da sé. Una scelta che i mercati – e i suoi uomini piazzati nelle istituzioni europee – non permetteranno che si ripeta.
L'Islanda è un'isola di sole di 320mila anime – il paese europeo meno popolato se si escludono i micro-stati – privo di esercito. Una città come Bari spalmata su un territorio vasto 100mila chilometri quadrati, un terzo dell'intera Italia, situato un poco a sud dell'immensa Groenlandia.
15 anni di crescita economica avevano fatto dell'Islanda uno dei paesi più ricchi del mondo. Ma su quali basi poggiava questa ricchezza? Il modello di 'neoliberismo puro' applicato nel paese che ne aveva consentito il rapido sviluppo avrebbe ben presto presentato il conto. Nel 2003 tutte le banche del paese erano state privatizzate completamente. Da allora esse avevano fatto di tutto per attirare gli investimenti stranieri, adottando la tecnica dei conti online, che riducevano al minimo i costi di gestione e permettevano di applicare tassi di interesse piuttosto alti. IceSave, si chiamava il conto, una sorta del nostrano Conto Arancio. Moltissimi stranieri, soprattutto inglesi e olandesi vi avevano depositato i propri risparmi.
Così, se da un lato crescevano gli investimenti, dall'altro aumentava il debito estero delle stesse banche. Nel 2003 era pari al 200 per cento del prodotto interno lordo islandese, quattro anni dopo, nel 2007, era arrivato al 900 per cento. A dare il colpo definitivo ci pensò la crisi dei mercati finanziari del 2008. Le tre principali banche del paese, la Landsbanki, la Kaupthing e la Glitnir, caddero in fallimento e vennero nazionalizzate; il crollo della corona sull'euro – che perse in breve l'85 per cento – non fece altro che decuplicare l'entità del loro debito insoluto. Alla fine dell'anno il paese venne dichiarato in bancarotta.
Il Primo Ministro conservatore Geir Haarde, alla guida della coalizione Social-Democratica che governava il paese, chiese l’aiuto del Fondo Monetario Internazionale, che accordò all'Islanda un prestito di 2 miliardi e 100 milioni di dollari, cui si aggiunsero altri 2 miliardi e mezzo da parte di alcuni Paesi nordici. Intanto, le proteste ed il malcontento della popolazione aumentavano.
A gennaio, un presidio prolungato davanti al parlamento portò alle dimissioni del governo. Nel frattempo i potentati finanziari internazionali spingevano perché fossero adottate misure drastiche. Il Fondo Monetario Internazionale e l'Unione Europea proponevano allo stato islandese di di farsi carico del debito insoluto delle banche, socializzandolo. Vale a dire spalmandolo sulla popolazione. Era l'unico modo, a detta loro, per riuscire a rimborsare il debito ai creditori, in particolar modo a Olanda ed Inghilterra, che già si erano fatti carico di rimborsare i propri cittadini.
Il nuovo governo, eletto con elezioni anticipate ad aprile 2009, era una coalizione di sinistra che, pur condannando il modello neoliberista fin lì prevalente, cedette da subito alle richieste della comunità economica internazionale: con una apposita manovra di salvataggio venne proposta la restituzione dei debiti attraverso il pagamento di 3 miliardi e mezzo di euro complessivi, suddivisi fra tutte le famiglie islandesi lungo un periodo di 15 anni e con un interesse del 5,5 per cento.
Si trattava di circa 100 euro al mese a persona, che ogni cittadino della nazione avrebbe dovuto pagare per 15 anni; un totale di 18mila euro a testa per risarcire un debito contratto da un privato nei confronti di altri privati. Einars Már Gudmundsson, un romanziere islandese, ha recentemente affermato che quando avvenne il crack, “gli utili [delle banche, ndr] sono stati privatizzati ma le perdite sono state nazionalizzate”. Per i cittadini d'Islanda era decisamente troppo.
Fu qui che qualcosa si ruppe. E qualcos'altro invece si riaggiustò. Si ruppe l'idea che il debito fosse un'entità sovrana, in nome della quale era sacrificabile un'intera nazione. Che i cittadini dovessero pagare per gli errori commessi da un manipoli di banchieri e finanzieri. Si riaggiustò d'un tratto il rapporto con le istituzioni, che di fronte alla protesta generalizzata decisero finalmente di stare dalla parte di coloro che erano tenuti a rappresentare.
Accadde che il capo dello Stato, Ólafur Ragnar Grímsson, si rifiutò di ratificare la legge che faceva ricadere tutto il peso della crisi sulle spalle dei cittadini e indisse, su richiesta di questi ultimi, un referendum, di modo che questi si potessero esprimere.
La comunità internazionale aumentò allora la propria pressione sullo stato islandese. Olanda ed Inghilterra minacciarono pesanti ritorsioni, arrivando a paventare l'isolamento dell'Islanda. I grandi banchieri di queste due nazioni usarono il loro potere ricattare il popolo che si apprestava a votare. Nel caso in cui il referendum fosse passato, si diceva, verrà impedito ogni aiuto da parte del Fmi, bloccato il prestito precedentemente concesso. Il governo inglese arrivò a dichiarare che avrebbe adottato contro l'Islanda le classiche misure antiterrorismo: il congelamento dei risparmi e dei conti in banca degli islandesi. “Ci è stato detto che se rifiutiamo le condizioni, saremo la Cuba del nord – ha continuato Grímsson nell'intervista - ma se accettiamo, saremo l’Haiti del nord”.
A marzo 2010, il referendum venne stravinto, con il 93 per cento delle preferenze, da chi sosteneva che il debito non dovesse essere pagato dai cittadini. Le ritorsioni non si fecero attendere: il Fmi congelò immediatamente il prestito concesso. Ma la rivoluzione non si fermò. Nel frattempo, infatti, il governo – incalzato dalla folla inferocita – si era mosso per indagare le responsabilità civili e penali del crollo finanziario. L'Interpool emise un ordine internazionale di arresto contro l’ex-Presidente della Kaupthing,Sigurdur Einarsson. Gli altri banchieri implicati nella vicenda abbandonarono in fretta l'Islanda.
In questo clima concitato si decise di creare ex novo una costituzione islandese, che sottraesse il paese allo strapotere dei banchieri internazionali e del denaro virtuale. Quella vecchia risaliva a quando il paese aveva ottenuto l'indipendenza dalla Danimarca, ed era praticamente identica a quella danese eccezion fatta per degli aggiustamenti marginali (come inserire la parola 'presidente' al posto di 're').
Per la nuova carta si scelse un metodo innovativo. Venne eletta un'assemblea costituente composta da 25 cittadini. Questi furono scelti, tramite regolari elezioni, da una base di 522 che avevano presentato la candidatura. Per candidarsi era necessario essere maggiorenni, avere l'appoggio di almeno 30 persone ed essere liberi dalla tessera di un qualsiasi partito.
Ma la vera novità è stato il modo in cui è stata redatta la magna charta. "Io credo - ha detto Thorvaldur Gylfason, un membro del Consiglio costituente - che questa sia la prima volta in cui una costituzione viene abbozzata principalmente in Internet".
Chiunque poteva seguire i progressi della costituzione davanti ai propri occhi. Le riunioni del Consiglio eranotrasmesse in streamingonline e chiunque poteva commentare le bozze e lanciare da casa le proprie proposte. Veniva così ribaltato il concetto per cui le basi di una nazione vanno poste in stanze buie e segrete, per mano di pochi saggi. La costituzione scaturita da questo processo partecipato di democrazia diretta verrà sottoposta al vaglio del parlamento immediatamente dopo le prossime elezioni.
Ed eccoci così arrivati ad oggi. Con l'Islanda che si sta riprendendo dalla terribile crisi economica e lo sta facendo in modo del tutto opposto a quello che viene generalmente propagandato come inevitabile. Niente salvataggi da parte di Bce o Fmi, niente cessione della propria sovranità a nazioni straniere, ma piuttosto un percorso di riappropriazione dei diritti e della partecipazione.
Lo sappiano i cittadini greci, cui è stato detto che la svendita del settore pubblico era l'unica soluzione. E lo tengano a mente anche quelli portoghesi, spagnoli ed italiani. In Islanda è stato riaffermato un principio fondamentale: è la volontà del popolo sovrano a determinare le sorti di una nazione, e questa deve prevalere su qualsiasi accordo o pretesa internazionale. Per questo nessuno racconta a gran voce la storia islandese.
Fare come l'Islanda, sconfiggere le banche per fermare la crisi senza fine!
Search
Questo blog nasce proprio nell'intento di condividere opinioni, idee, esperienze, progetti, filosofie, culture, modelli di sviluppo alternativi e/o complementari che per la prima volta, forse, ci permettano di sentirci un POPOLO unito che ha la consapevolezza, la forza e la capacità di scegliere il proprio futuro per sè e per le generazioni a venire. Un popolo che urla la propria indignazione verso quella classe politica cinica ed autoreferenziale che interpretando la politica come mezzo ad uso esclusivo proprio e dei propri affini a vantaggio personale e clientelare ha spezzato la catena di congiunzione con l'elettorato attivo, non fornendo risposte, non risolvendo problemi. Non resta che rimboccarci le maniche, fare politica attiva, dare il proprio contributo! ciascuno di noi, nel proprio piccolo, può fare grande l'italia! Che ognuno di noi possa interpretare nel proprio quotidiano, con il proorio lavoro, le proprie aspirazioni, i propri sogni il CAMBIAMENTO che vorremmo vedere nella nostra bella ITALIA!
La più grande difficoltà sta nell'interpretare la politica come un mezzo al servizio della collettività, della giustizia sociale, uno strumento utile a migliorare la qualità della vita di tutti noi. gli anni trascorsi dal '94 ad oggi hanno segnato le menti, le coscienze ed i cuori, riempendoli di scontri verbali, contrapposizioni ideologiche, dietrologie politiche, lotte di classe. Tutto ciò fa gioco alla oligarchia classista avida di potere che detiene non soltanto il potere politco, ma soprattutto, il potere economico e finaziario di questo paese. In realtà "gli affari" vengono fatti con l'accordo di tutti trasversalmente ad ogni "finta ideologia" politica. La politica degli opposti schieramenti, delle tifoserie selvagge, della contrapposizione liberista-comunista è nella realtà odierna una assurda amenità anacronistica utile soltanto al conservatorismo liberista finto riformista che così continua a tenere sotto scacco le capacità imprenditoriali, i talenti intellettuali, la voglia di "cambiamento" di questo paese. Facciamo che queste eccellenze non rimangano inespresse: lottiamo "insieme" senza inutili contrapposizioni ideologiche. Una cosa ci accomuna tutti: l'amore per il nostro paese. lottiamo insieme per costruire un futuro migliore per tutti!
Powered by Blogger.
Blog Archive
-
▼
2012
(278)
-
▼
novembre
(25)
- E non se ne vuole andare....
- ILVA un pasticcio chiamato ITALIA
- Primarie di produttività
- EUROPA: cardiogramma piatto
- INequitalia: storie di ordinaria ESTORSIONE
- LAVORATORI! TIE' !! No al TAGLIO degli STIPENDI de...
- Italia verso il DEFAULT, loro giocano alle PRIMARIE
- ATTENTATO A TEL AVIV: STOP THE WAR!
- Lo shadow banking vale 67 mila miliardi di dollari...
- STOP THE WAR
- Berlu scarica(barile) Monti
- I "Tecnici" del manganello
- CAMBIARE: SI PUO'!!
- Ministri in fuga....da una crisi infinita
- Regione Lazio, arrestato l’ex capogruppo Idv Maruc...
- Obama, "il Presidente" ed il futuro del mondo
- Di Pietro non è un santo ma REPORT ha preso un gra...
- Fare come l'Islanda, sconfiggere le banche per fer...
- Brucia la Grecia... ed anche la speranza
- Grazie a quel pagliaccio di Berlusconi per andare ...
- USA & CINA: elezioni e congresso PCC, il futuro de...
- Berlusconi scuse non bastano! che paghi i danni pr...
- L'AMERICA DEI PROSSIMI QUATTRO ANNI
- Marchionne, la RAPPRESAGLIA
- Monti e la Manovra: più tasse per tutti! Preparate...
-
▼
novembre
(25)
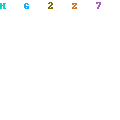
0 Comments Received
Leave A Reply