
L’America è alla vigilia di una scelta epocale. L’esito delle elezioni presidenziali di novembre condizionerà la sua politica sociale ed economica per ben più dei prossimi quattro anni. Se l’America rieleggerà Obama, vorrà dire che desidera avvicinarsi allo stato sociale di tipo europeo. Se eleggerà il candidato repubblicano Romney vorrà dire che desidera tornare all’individualismo o “eccezionalismo” che la distinse fino all’età di Roosevelt, gli anni trenta. Nel primo caso sarà un’America più assistenzialista e statalista dell’attuale, che ridistribuirà maggiormente il reddito tassando di più i ricchi, e che regolamenterà maggiormente la finanza. Nel secondo caso, sarà un’America al servizio del mercato, dove i cittadini dovranno “fare da sé”.
I liberisti e i repubblicani sostengono che la prima America, quella di Obama, si indebiterebbe come l’Europa a causa degli oneri della sanità pubblica, delle pensioni e degli altri servizi sociali: a lungo andare sarebbe costretta a praticare l’austerity e l’economia americana si paralizzerebbe. A loro giudizio, invece, la seconda America sfrutterebbe appieno le sue risorse per promuovere gli investimenti e la crescita economica, generando un “boom” e premiando il merito dei singoli.
Il modello socioeconomico di Obama, insomma, sarebbe insostenibile, quello di Romney sostenibile. Naturalmente, i keynesiani e i democratici la pensano al contrario: essi osservano che l’America al servizio del mercato è quella delle megacrisi del 1929 e del 2008. L’esito delle elezioni presidenziali americane di novembre peserà anche sull’Europa, a cui sarebbe più facile trattare con l’America di Obama che con quella di Romney. Ma l’Europa può solo sperare che gli americani non si lascino abbacinare dal mito del loro “eccezionalismo”. La questione di fondo infatti, oggi come nella Grande depressione degli Anni trenta, non è tanto se lo stato sociale sia sostenibile, quanto se lo sia il capitalismo. La crisi finanziaria ed economica ha messo in discussione il capitalismo così come viene praticato a Wall street. Si diffonde il timore che nella forma attuale sia insostenibile. La politica non può accettare che, quasi ovunque, conduca a poche faraoniche ricchezze da un lato e a una dilagante povertà dall’altro. E che con le sue aberrazioni, come i derivati in borsa e una disoccupazione giovanile di oltre il 30 per cento, minacci lo stato.
Di capitalismo sostenibile si parla in America da prima del “crack” del 2008. Uno dei più autorevoli a proporlo fu il sociologo ed economista Bob Reich, ministro del lavoro sotto il presidente Bill Clinton. L’industria e la finanza, sostenne Reich, devono rispondere non solo agli “shareholders”, agli azionisti, ma anche agli “stakeholders”, coloro i cui interessi sono messi in gioco dagli investimenti dei ricchi, cioè ai cittadini, perché il loro operato ha un profondo impatto, non sempre positivo, sulla società civile. Adesso, i campioni del capitalismo sostenibile sono David Blood, un ex dirigente della Goldman Sachs, e Al Gore, l’ex vice di Clinton, fondatori della Generation investment managment, un fondo “verde”. A loro parere, se non si darà un codice di condotta, il capitalismo globalizzato provocherà una serie di catastrofi.
Che cosa s’intende per capitalismo sostenibile? Secondo Blood e Gore un capitalismo dove la finanza “appoggi una duratura crescita economica” e dove “analizzi gli effetti delle sue azioni sul pubblico e sullo stato, per comportarsi di conseguenza”. Al momento, protestano i due, la condotta della finanza è irresponsabile: “La sua ossessione del profitto istantaneo” ammoniscono “rende volatile il mercato, accresce la sperequazione e lede l’ambiente”. Stando a Blood e Gore, una delle misure più urgenti sarebbe l’abolizione del profitto trimestrale come metro di misura del successo di una società finanziaria (e di una impresa industriale): “La scelta di un così breve termine è irrazionale e controproducente”. Un’altra sarebbe il divieto ai fondi pensionistici di fare investimenti a rischio. Una terza sarebbe la lotta alle speculazioni in borsa. Sono riforme controverse e di difficile attuazione, poste sovente sul tappeto, sino ad ora invano, anche in Italia, a una conferenza dello Aspen Institute a Roma nel 2009. Ma sono riforme improcrastinabili.
Il libro “Il capitalismo sostenibile: una questione di buon senso” è la Bibbia di questo movimento. Lo scrisse l’economista John Ikerd, una sorta di pentito del liberismo esasperato dell’ultimo trentennio, che già nel 2007 ricordò a tutti che Adam Smith, Ricardo e altri maestri del capitalismo “lo inquadrarono in una società morale e giusta”. E’ necessario reintegrarvi i valori etici di un tempo, proclamò Ikerd, o esso diverrà incompatibile con la democrazia, che si basa sul progresso economico e sociale e sulla dignità della persona. Una posizione analoga a quella delle chiese, il Vaticano in testa, sempre più allarmate dalla crisi. Il “Manifesto”, come il Wall street journal ha chiamato il progetto di Blood e Gore, quasi fossero Marx 2, sembrerà rivoluzionario ai liberisti e ai repubblicani, che agitano davanti all’elettorato americano lo spauracchio del “socialismo all’europea”. Ma non lo sembra a Obama e ai democratici, che lo hanno abbracciato nella campagna elettorale in corso, pur senza dirlo espressamente. Tanto meno lo sembra alla maggioranza dei politici europei per i quali, a differenza dei conservatori e dei ras della finanza americani, l’equità deve essere un principio fondamentale del capitalismo. Come avverte Ikerd, il capitalismo insostenibile finirebbe per esautorare di fatto la democrazia. Gli stati e i cittadini ne diverrebbero ostaggi, e anziché andare avanti il mondo farebbe un pericoloso passo indietro.
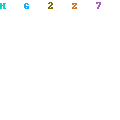
0 Comments Received
Leave A Reply