Search
Questo blog nasce proprio nell'intento di condividere opinioni, idee, esperienze, progetti, filosofie, culture, modelli di sviluppo alternativi e/o complementari che per la prima volta, forse, ci permettano di sentirci un POPOLO unito che ha la consapevolezza, la forza e la capacità di scegliere il proprio futuro per sè e per le generazioni a venire. Un popolo che urla la propria indignazione verso quella classe politica cinica ed autoreferenziale che interpretando la politica come mezzo ad uso esclusivo proprio e dei propri affini a vantaggio personale e clientelare ha spezzato la catena di congiunzione con l'elettorato attivo, non fornendo risposte, non risolvendo problemi. Non resta che rimboccarci le maniche, fare politica attiva, dare il proprio contributo! ciascuno di noi, nel proprio piccolo, può fare grande l'italia! Che ognuno di noi possa interpretare nel proprio quotidiano, con il proorio lavoro, le proprie aspirazioni, i propri sogni il CAMBIAMENTO che vorremmo vedere nella nostra bella ITALIA!
La più grande difficoltà sta nell'interpretare la politica come un mezzo al servizio della collettività, della giustizia sociale, uno strumento utile a migliorare la qualità della vita di tutti noi. gli anni trascorsi dal '94 ad oggi hanno segnato le menti, le coscienze ed i cuori, riempendoli di scontri verbali, contrapposizioni ideologiche, dietrologie politiche, lotte di classe. Tutto ciò fa gioco alla oligarchia classista avida di potere che detiene non soltanto il potere politco, ma soprattutto, il potere economico e finaziario di questo paese. In realtà "gli affari" vengono fatti con l'accordo di tutti trasversalmente ad ogni "finta ideologia" politica. La politica degli opposti schieramenti, delle tifoserie selvagge, della contrapposizione liberista-comunista è nella realtà odierna una assurda amenità anacronistica utile soltanto al conservatorismo liberista finto riformista che così continua a tenere sotto scacco le capacità imprenditoriali, i talenti intellettuali, la voglia di "cambiamento" di questo paese. Facciamo che queste eccellenze non rimangano inespresse: lottiamo "insieme" senza inutili contrapposizioni ideologiche. Una cosa ci accomuna tutti: l'amore per il nostro paese. lottiamo insieme per costruire un futuro migliore per tutti!
Powered by Blogger.
Blog Archive
-
▼
2011
(179)
-
▼
luglio
(48)
- E' un governo "Ad Personam", mentre l'italia ineso...
- BARACK OBAMA: «TEMPO SCADUTO» L'INCUBO "DEFAULT" E...
- Se il politico è un evasore....
- A.A.A. Sindacato Cercasi
- Euro stangata per Mediaset
- Dark Pools, speculando con la nostra vita
- BERLU-ALITALIA, come perdere 7 miliardi e farli pa...
- Breivik e la destra europea, 1941-2011 (di Gad Ler...
- Travaglio Vs Bersani/2 (rapporto politica/affari)
- E se Fallissero gli USA?
- Strage di Oslo, il cuore oltre la bestialità
- Breivik, viaggio nell'infanzia e nella mente di un...
- I ladri e i Penati (Travaglio Vs Bersani)
- Oslo, la guerra del "terrore"
- Scusa Indro, sul Caimano avevi ragione tu
- Pd, il giorno dei sospetti. E D’Alema attacca: “Vo...
- "Abbiamo la classe politica più vecchia più assent...
- Il Palazzo si sgretola
- Stop alle spese militari! Investiamo nel futuro e ...
- Vertice UE, lanciata la "ciambella" per salvare l'...
- Uscire dall'Euro: scenario possibile?
- la mela è marcia ed i vermi mangiano da destra e d...
- Genova, G8: 10 anni dopo. Globalizzazione oggi
- Torna pure l'ICI !!!! più TASSE per TUTTI!
- Capitalismo e Rivoluzione liberale: fallimento di ...
- Paolo Borsellino: storia di un magistrato ucciso d...
- ITALIA, l'ora della verità: gli scenari possibili
- Scuse e Dimissioni: dettagli non trascurabili
- LA CASTA vien di notte...e come sempre ruba!!!!!
- FINANZIARIA: Nessun Taglio alla CASTA, più TASSE p...
- sull'orlo del baratro....
- Minzolini VS Garimberti
- La tempesta (finanziaria) perfetta
- Libertà è partecipazione!
- Berlusconi-Tremonti, fine di un amore
- Grandi aziende (FIAT O MEDIASET) non pagano tasse!
- Silvio è rovinato: deve 560 milioni a De Benedetti
- Un nuovo modello di sviluppo
- Travaglio VS D'Alema
- Rivoluzione in Islanda ma nessuno ne parla!
- RESTIAMO UMANI
- Concita, semplicemente grazie!
- Una proposta concreta
- concita, mia amica!
- Democrazia "su misura"
- val di susa e dintorni...
- “Così Silvio ha fatto saltare la trattativa Santor...
- SANTORO: “I POLITICI NON MI VOGLIONO MA TORNO CON ...
-
▼
luglio
(48)

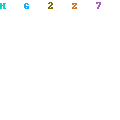
0 Comments Received
Leave A Reply